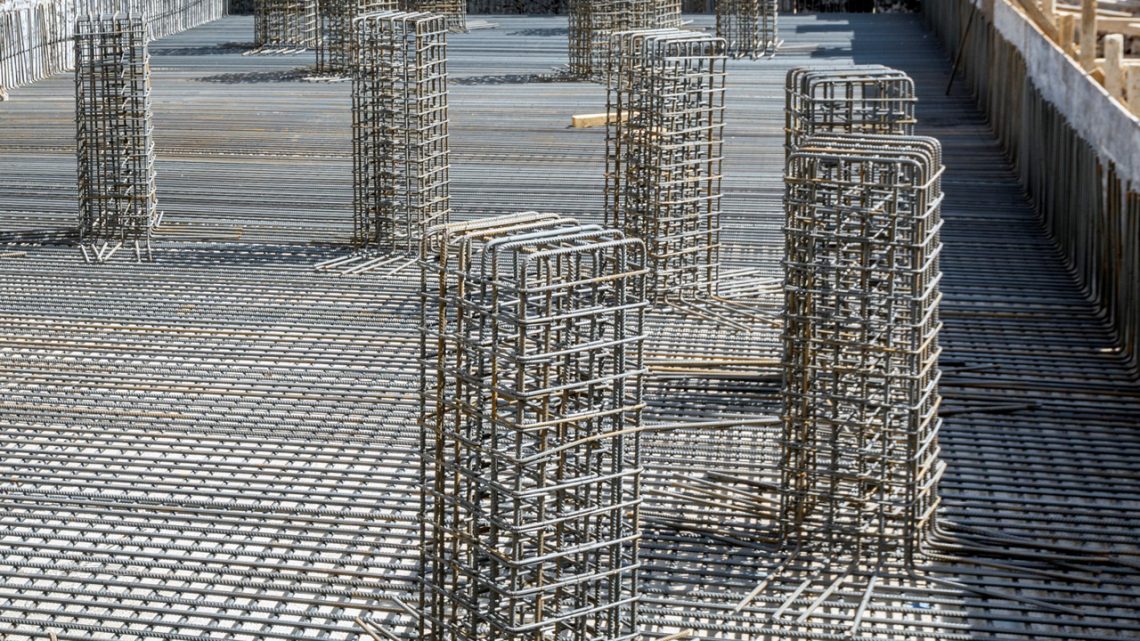
Tecnica e proiezione del sé, senza luoghi
In un suo scritto dal titolo La tecnica come proiezione degli organi, Pavel Florenskij pone una geniale interpretazione della genesi della tecnica come proiezione degli organi fisici. La tecnica, secondo Florenskij, nasce nel momento in cui un essere umano ha bisogno di esternare la funzione di un proprio organo, di proiettare fuori di sé funzioni che già possiede dentro di sé. Questo, tuttavia, implica che il corpo umano sia interpretato già come un corpo che funziona, come un organo complesso, che “funziona”. Il progresso tecnico, dunque, sembra evolversi con le capacità dell’essere umano di scoprire e interpretare il proprio corpo. Dapprima nelle sue funzioni motorie, in seguito come un meccanismo ripetitivo, poi come una macchina complessa, infine come un organismo vivente. Tutte interpretazioni, segni, tracce dell’organismo umano che esprimono il significato che l’essere umano ha attribuito al proprio corpo e, in buona sostanza, anche la percezione che noi abbiamo del nostro corpo. Esempi molto banali di questa relazione fra corpo e tecnica è data dalla zappa prolungamento del braccio, dalla forchetta proiezione della mano, dalle lenti come proiezione dello sguardo e così via. Curiosamente, in questo contesto non rientrerebbe la ruota, la quale non ha una proiezione immediata del nostro corpo, quanto una funzione secondaria come movimento. Anche se i significati si evolvono, cambiano, mutano e acquisiscono nuovi sensi, ciò che rimane è questa relazione fra il corpo e la tecnica. Dunque, se la tecnica nasce in questo contesto, come proiezione della percezione che abbiamo del nostro corpo, questo ci pone degli interrogativi da una parte sul come interpretare un corpo e dall’altra sugli effetti che questo legame fra tecnica e corpo esercita sull’ambiente stesso. il primo problema che sorge, infatti, è l’accorgersi di come la tecnica nasca come proiezione del nostro corpo ma che, al tempo stesso, la tecnica influisca nella percezione che abbiamo del corpo, di come siamo e di come ci vediamo. In modo particolare, nella nostra contemporaneità, questo fenomeno emerge nell’utilizzo della tecnologia virtuale, nella continua proiezione specchiata del nostro corpo, di come ci vediamo affinché gli altri ci vedano come noi vorremmo essere visti. Se, dunque, la proiezione di un corpo nella tecnica contribuisce all’evoluzione della tecnica stessa, dall’altra parte la tecnica stessa fa nascere un corpo tecnologizzato, nella costante ansia di proiettarsi al di fuori. Ma la complessità della relazione fra tecnica e corpo non può prescindere dall’ambiente in cui viviamo e che viviamo. Un ambiente che, paradossalmente, rimane anonimo rispetto alla proiezione del corpo in una tecnologia virtuale. Sostanzialmente, perché il virtuale consiste proprio nella deterritorializzazione, in uno sganciamento tecnico dall’ambiente sociale e, in particolare, urbano in cui viviamo. Fenomeno latente nelle nostre città, la tecnica non è solo strumento ma anche percezione del proprio corpo sganciato dalla città in cui viviamo. Un bar, un supermercato, uno specchio dinanzi a cui ci fotografiamo potrebbero essere, al tempo stesso, da ogni parte e in nessun luogo. Conseguenze di questo, dunque, non portano solo alla continua produzione tecnica di immagini del sé, del proprio corpo, ma anche ad una sorta di assuefazione della relazione fra tecnica e corpo. Assuefazione che vuol dire indifferenza e sganciamento di una tecnica dal corpo, in quanto il corpo stesso è evanescente, fumoso, proiettato. Paradosso di una proiezione di sé in ogni contesto e sganciati da ogni territorio: organi come proiezione tecnica del sé, senza luoghi.